Inizio, finalmente, una serie di articoli dedicati alle storie disneyane pubblicate negli Stati Uniti dalla Marvel Comics.
La maggior parte di queste storie appartengono alla serie dei What If...?, ovvero storie in cui gli autori immaginano cosa sarebbe successo a un dato supereroe, se non addirittura all'intero Universo Marvel, nel caso in cui venisse modificato un piccolo dettaglio della storia considerata canonica. La storia con cui è iniziata questa serie di pubblicazioni, però, non appartiene propriamente ai What If...? supereroistici, anche se è in effetti una variazione su una delle storie classiche di Paperon de' Paperoni.
The Infinity Dime, infatti, storia scritta da Jason Aaron e disegnata da un nutrito gruppo di autori italiani, gente come Paolo Mottura, Francesco D’Ippolito, Alessandro Pastrovicchio, Vitale Mangiatordi, Giada Perissinotto, introduce una specie di multiverso paperoniano, cosa che mi ha permesso di discutere nuovamente e in maniera un po' più estesa rispetto a Durkwing Duck del concetto di multiverso.
Vi lascio quindi subito qui sotto il video sul canale YouTube che è suddiviso in due parti, una dedicata alla storia e l'altra ai concetti scientifici. Potete tranquillamente vedere direttamente il video saltando la lettura del resto, che è un adattamento di quanto scrissi in occasione della pubblicazione italiana su Topolino #3579.
Storia scientifica del multiverso

Poiché comunque la newsletter si occupa essenzialmente della scienza nei fumetti di supereroi, ho deciso di non riproporre la parte più prettamente fumettistica, che comunque potete leggere direttamente nell'articolo che ho linkato in precedenza. Dal punto di vista scientifico, invece, mi concetrerò su tre modelli matematici che prevederebbero tre versioni abbastanza differenti del multiverso.
La prima storia inizia tra il 1955 e il 1956 quando Hugh Everett, che aveva assistito all’ultima conferenza pubblica di Albert Einstein (era il 14 aprile del 1954), portò a conclusione la sua tesi di dottorato. Con la supervisione di John Wheeler, aveva colto spunto da una delle frasi dette da Einstein nel corso della conferenza:
E’ difficile credere che questa descrizione1 sia completa. Sembra rendere il mondo nebuloso a meno che qualcuno, un topo per esempio, non lo stia guardando. E’ credibile che lo sguardo di un topo possa cambiare considerevolmente l’universo?
In estrema sintesi il lavoro di Everett si concentrò su una interpretazione della meccanica quantistica che definiva dei molti osservatori e che mirava a descrivere la funzione d'onda dell'universo nella sua interezza. Quest'ultima, detta anche universale, è secondo Everett la sovrapposizione delle funzioni d'onda parziali che tengono conto della memoria e delle osservazioni di ciascun componente dell'universo. Inoltre il concetto di universalità della funzione d'onda implica che ciascuna funzione d'onda parziale è dunque in grado di estendersi in tutto l'universo senza limitarsi, per esempio, a una scatola. Secondo Everett, infine, ciascun elemento si evolve in maniera deterministica, ma gli aspetti statistici e probabilistici emergono dalla natura molteplice della meccanica quantistica, che realizza e mette in atto tutte le possibilità.
In particolare il riferimento alla scatola fatto poc'anzi rimanda direttamente al famoso esperimento mentale proposto da Erwin Schrodinger sul gatto nella scatola, che se visto dal punto di vista della meccanica quantistica sarebbe in una sovrapposizione tra essere vivo ed essere morto. In questo modo, spingendo alle estreme conseguenze il modello di Everett, emergerebbe un multiverso in un certo senso ad albero, in cui qualunque scelta non compiuta da ciascun abitante dell’universo, sarebbe in realtà avvenuta in un universo parallelo.
Di fatto questo multiverso sarebbe il più simile a quelli prodotti da DC Comics e Marvel che in pratica propongo variazioni più o meno lontane sui propri supereroi.
Dalle stringhe alle bolle
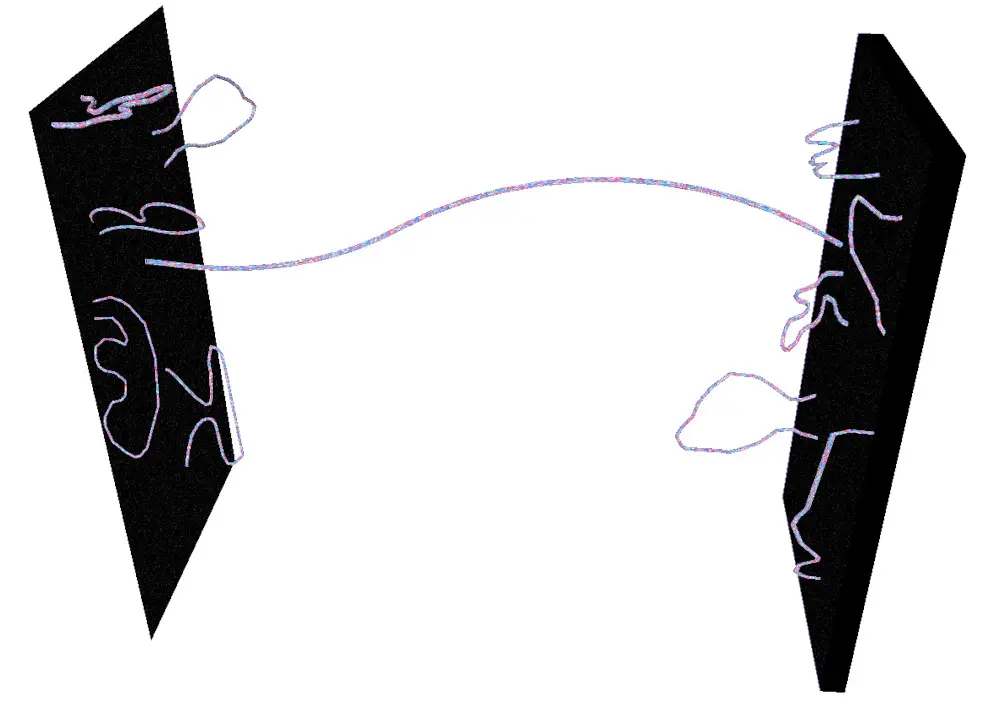
Un secondo modo di vedere il multiverso, che peraltro in qualche modo è stato utilizzato da Grant Morrison su The Invisibles, è tramite la teoria delle stringhe. Questa è stato il primo modello matematico che ha proposto una unificazione della teoria della relatività generale con la meccanica quantistica. Lo spazio geometrico all'interno del quale si sviluppa tale teoria è a più dimensioni e, in particolare, al suo interno si "muovono" delle membrane (o brane, usando il termine tecnico) che, collidendo una con l'altra, creano universi, che ovviamente definiremmo paralleli. In questo caso, però, non sarebbero variazioni uno dell'altro, ma universi completamente diversi, con quantità di energia e di materia diverse e, forse, anche con leggi della fisica differenti.
Una cosa del genere, ovvero universi paralleli con leggi della fisica differenti, avviene, anche se in termini leggermente diversi, avviene anche con il terzo modello che vi sto per citare, l'inflazione cosmica.
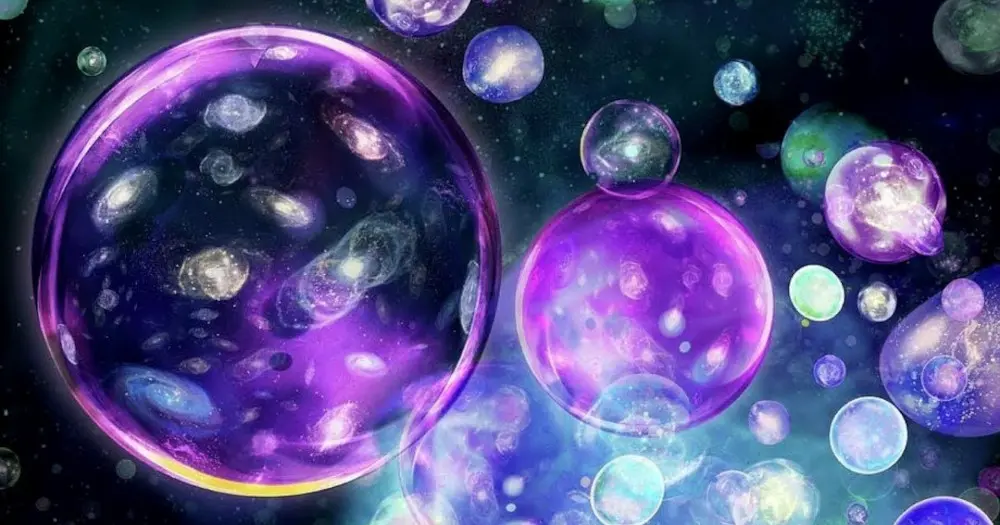
Quest'ultima è una teoria, molto ben verificata, che descrive i primi istanti dell’universo secondo cui a un certo punto lo spaziotempo si è espanso a velocità superiori a quella della luce. Questo non viola i principi di relatività, in particolare quello sulla velocità della luce, perché la materia ancorata nelle varie porzioni dello spaziotempo ha continuato a muoversi alle usuali velocità. Se, come suggerisce l'interpretazione più estrema dell'inflazione cosmica, questi periodi si alternano nel corso della vita dell'universo, allora è possibile che queste porzioni di spaziotempo di fatto risultano separate e irraggiungibili una dall'altra con valori delle costanti fisiche differenti e quindi con leggi della fisica che funzionano in maniera leggermente differente una dall'altra. Queste porzioni di spaziotempo sono dette universi bolla e il nostro sarebbe uno dei tanti di questi universi, che quindi sarebbero in realtà delle aree irraggiungibili e incomunicabili all'interno di uno spazio più grande che sarebbe in realtà il vero universo.
Tutto quello che ho raccontato, però, non è verificabile e anche se una qualunque delle teorie citate o altre non citate dovesse venire parzialmente verificata, ciò non implicherebbe automaticamente l'esistenza del multiverso. Anzi, per molti fisici teorici e non solo, è molto improbabile la sua esistenza, ma nonostante questa posizione, che in parte condivido, vorrei comunque chiudere con quanto scriveva nel biglietto di addio Liz Everett prima di suicidarsi:
Vi prego di buttarmi nell’acqua… o nella spazzatura, forse così finirò nell’universo parallelo giusto insieme con mio padre.2
Riepilogo link
Come in altre occasioni, riepilogo qui sotto i link espliciti degli articoli presenti nel testo:
- dropseaofulaula.blogspot.com/2024/06/topolino-3579-lelettrodinamica.html
- http://www.lospaziobianco.it/alcaffedelcappellaiomatto/topolino-3579-the-infinity-dime-e-i-segreti-del-multiverso/
- dropseaofulaula.blogspot.com/2018/07/la-lama-sottile-ovvero-del-multiverso-e.html
- dropseaofulaula.blogspot.com/2011/11/00909090909-il-gatto-di-schroedinger-e.html
- quaily.com/scienza-supereroi/p/absolute-power-4-fisica-mai-vista
